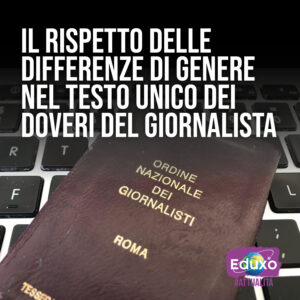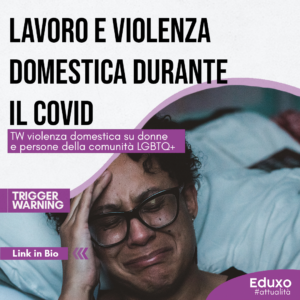La cittadinanza permette il pieno riconoscimento dei diritti e dell’individuo di fronte all’ordinamento giuridico dello Stato.
Nel nostro Paese, però, può essere anche considerato un privilegio. In un suo recente post, Djarah Kan, scrive:
‘Questa è la mia tessera elettorale. È mia e di nessun altro. Con questa tessera oggi, per la prima volta dopo 27 anni, ho esercitato il mio diritto di voto. Nel 2018 sono diventata cittadina italiana, nata a Santa Maria Capua Vetere. Nella provincia del Ghana? Eh no, in quella di Caserta. Che ridere, eh?’.
Infatti, in Italia, si è cittadin* per nascita se:
- figl* di almeno un* genitor* italiano
- nat* nel territorio della Repubblica, con entrambi *l* genitor* ignot* o apolid*.
La cittadinanza italiana si acquisisce:
- a seguito di adozione
- a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età de* figl*
- per beneficio di legge, cioè quando sussistono i requisiti di fatto e di diritto previsti nell’articolo 4.
- attraverso lo ‘iuris communicatio’, essendo coniuge di cittadin* italian* e residente legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica.
- grazie alla ‘naturalizzazione’, quando sussistono i requisiti dell’articolo 9 della legge numero 91 del ‘92.
La cittadinanza determina e garantisce i diritti civili e politici dell’individuo e permette il pieno riconoscimento de* cittadin*.
Ma cosa realmente significa, nel nostro Paese, essere italian*?
Le controversie sono all’ordine del giorno: mentre nei telegiornali sembra esserci quasi un motivo di vanto nel pensare che Jill (Jacobs) Biden, nuova First Lady U.S.A, sia ‘italoamericana’ (il nonno materno era siciliano), le problematiche relative all’accesso alla cittadinanza italiana sono ben più complesse e fanno riferimento all’articolo 22 della Costituzione e alla legge 91 del ‘92
In Italia l’accesso automatico alla cittadinanza avviene perlopiù secondo il principio dello ‘ius sanguinis’, ovvero il diritto ‘di sangue’.
In pratica, si è cittadin* italian* se almeno uno de* genitor* è italian* e quindi possiede a sua volta la cittadinanza.
L’acquisizione automatica, inoltre, avviene attraverso l’adozione (nel caso di un* minore adottato da cittadin* italian*) o il principio dello ‘ius soli’ (diritto ‘di suolo’) se *l* genitor* de* bambin* sono ignot* o apolid*.
L’acquisizione della cittadinanza invece si può richiedere nei casi particolari di ‘matrimonio’ e di ‘residenza’.
I termini e le condizioni per poter presentare la domanda sono in ogni caso specifici e spesso molto lunghi. Ricordiamo anche che l’impianto centrale per l’acquisizione della cittadinanza è rimasto pressoché invariato dal 1992.
In particolare escludendo le persone apolide, rifugiate e cittadin* di un altro Paese dell’Unione Europea, per cui i tempi sono diversificati, un* cittadin* stranier* (extra UE) può richiedere la cittadinanza ‘per naturalizzazione’ se residente legalmente e continuativamente in Italia da almeno 10 anni.
C’è inoltre l’obbligo di possedere i dati del reddito personale o di quello famigliare (garanzia dell’autosufficienza economica) e dimostrando di avere una buona conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1.
Oltre ai costi relativi alla richiesta le dinamiche alla base di questo processo vengono spesso discusse.
Nel nostro paese è stato stimato che solo il 17% de* immigrat* nat* all’estero ha ottenuto la cittadinanza italiana, mentre la media della Comunità Europea (i ‘vecchi’ e primi 15 membri) è di gran lunga maggiore e tocca il 34%, con tassi ancora più alti ad esempio nei Paesi Bassi o in Svezia, (seppur, considerando la totalità dei casi, i tempi per l’ottenimento della cittadinanza italiana siano leggermente minori rispetto alla media europea).
In generale, dobbiamo comunque considerare che la normativa per ottenere la cittadinanza in Italia è più rigida e spesso meno inclusiva rispetto alla media europea.
Ad esempio, per quanto riguarda lo ius soli, e *l* figl* di genitor* stranier* residenti in Italia da tempo, mentre esistono agevolazioni per i discendenti di cittadin* italian*.
Ad esempio, la richiesta da parte de* bambin* nati in Italia da genitor* stranier* che hanno trascorso l’infanzia nel Paese deve essere presentata entro un anno dal compimento dei 18 anni e vi sono anche delle regole severe rispetto alla durata di un’ipotetica non permanenza nel suolo italiano durante gli anni precedenti.
Inoltre, sempre rispetto alla media UE-15, i tempi per l’ottenimento della cittadinanza sono dilatati.
A differenza degli altri Paesi presi in considerazione, l’Italia si serve di ben tre enti per la ricezione delle richieste (prefetto, polizia e Ministero dell’Interno, a cui spetta la decisione finale) aumentando i procedimenti burocratici e dimostrandosi uno dei principali impedimenti all’efficienza della naturalizzazione ordinaria.
Un altro punto critico degno di nota è quello della conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica. Le procedure per dimostrare questo requisito sono spesso inique e arbitrarie, in quanto relativamente informali e di ‘diversa interpretazione’.
A proposito, vi ricordate il caso Suarez, che ha creato scalpore lo scorso settembre?
Ottenere la cittadinanza significa anche una maggiore integrazione (consapevoli che ci sia ancora molto da fare per quanto riguarda un aspetto ideologico più profondo e non meramente formale) e significa essere riconosciut* a tutti gli effetti da uno Stato che si ritiene il proprio.
Inoltre, secondo i dati, da un punto di vista pratico significa anche più facilità nel trovare lavoro e quindi migliori condizioni di vita. Inoltre, un altro aspetto fondamentale è quello legato al diritto di voto, quindi al poter partecipare attivamente alle sorti del futuro del proprio Paese.
Djarah Kan, scrittrice e attivista, in occasione dello scorso referendum testimonia sui social la sua esperienza:
‘[…] Fin da piccola mi hanno sempre detto che andare a votare non serviva a niente. Gli immigrati e i figli degli immigrati senza cittadinanza italiana non possono votare, anche se vivono lo stesso Paese di chi la tessera elettorale la usa come sotto bicchiere o la vende per 100 euro. […] E c’era paura, frustrazione, incertezza, perché quando sei straniero la tua presenza si gioca sul filo del rasoio.[…] Ma per gli altri, per quelli che non hanno avuto la mia fortuna, che forse non riusciranno mai ad uscire dal ricatto del Permesso di soggiorno e dell’invisibilità politica, non è ancora finita.’
Voi cosa ne pensate? Come vi inserite nel dibattito a favore dello ius soli?
FONTI
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/32271/ACIT_Handbook_Italy.pdf?sequence=1
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51985
Legge 91 del 1992